| << |
| Il Quotidiano della Basilicata |
Giovedí 3 Aprile 2003 |
|
| |
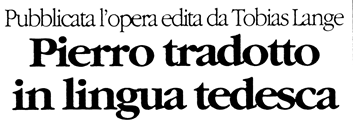 |
TURSI - "Messer
in der Sonne", suona così in tedesco "Curtelle
a lu sòue", titolo di un'opera del 1973 di
Albino Pierro, ed oggi scelto da Domenico Brancale e Tobias
Eisermann, insieme all'editore Clemens-Tobias Lange, per
un libretto che raccoglie trentanove poesie pierriane
per la prima volta tradotte in tedesco.
Il testo, edito in mille copie, raccoglie alcune tra le
più significative liriche di Pierro. "A jaramme",
"Le porte scritte nfàcce", "Nun
ci pozze accustè". tante per citarne alcune,
ed ogni poesia è accompagnata da un segno o meglio
una traccia che sostanzia un suono, un’idea, un’immagine.
Oltre al testo in tedesco e a quello in dialetto tursitano
a fronte, non manca una sezione che raccoglie le traduzioni
in italiano, ed alcune testimonianze di Tobias Eisermann
e di Domenico Brancale, che a propcsito di Pierro scrive:
«quando leggo la poesia di Pierro una sensazione
di verità s’impossessa della tana silenziosa
del mio cuore, una lama di luce attraversa la scorza della
mia resistenza…»
Ed è lo stesso Brancale a spigare la genesi di
quest’opera: «ho conosciuto alcuni anni fa
Tobias Eisermann per caso, forse per volontà della
poesia stessa, o per destino, come se in un certo qual
modo il libro stesso chiamasse e facesse in modo di farci
incontrare. Eisermann aveva sentito parlare di Pierro
e letto le sue poesie, ma non aveva potuto leggerlo attraverso
il dialetto, cosa che pote fare con il mio aiuto e da
allora è nata la nostra collaborazione. Il tedesco,
poi, è una lingua che Pierro conosceva ed amava,
ma è l’unica lingua in |
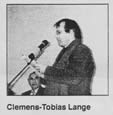 |
|
cui non era ancora stato tradotto, perciò
questo lavoro, assume un significato molto importante
anche aila luce dei tanti studi che sono stati
condotti ad opera di Heinric Lausberg. Gerbard
Rohles, eoc.
Questo libro è nato cosi, in un itinerario
continuo sulle tracce di Pierro e l’unica
persona che poteva materialmente fare questo libro
è l’editore, Tobias Lange, vici no
alla terra della poesia, alle cose, alla «carne»~.
Lange, pittore ed editore aggiunge: «ho
approfittato della presenza di Brancale e di Eiserman
per visitare ~ tanti posti qui in Lucania e ne
ho ricevuto una forte impressione: la luce è
forte, le ornbre sono nette, le persone sono chiare,
si esprimono in una maniera onesta, || diretta,
pulita».
Del testo ve ne è poi un edizione speciale,
stampata in pochissimi esemplari, davvero particolare:
stampata sulla carta del pane a voler i significare
il suo alto valore nell'avvolgere un alimento
tanto prezioso e quindi anche le parole della
poesia e la vita stessa. Al suo interno, e poi,
impreziosito da numerose tavole ove prendono forma
originali disegni di Tobias Lange. Un testo che
e si ammanta di una connotazione anche tattile,
da accarezzare, consumare e far viaggiare con
sé.
|
|
Teresa Crispino
|
|
|
|
| |
|
| |
Il CUBO
Contenitore mensile di informazioni Universitarie |
Febbraio 2003 |
|
| |
|
di Neil Novello
Albino Pierro, Curtelle
a lu sóue / Messer in der Sonne, CTL,
Hamburg 2003
La poesia di Albino Pierro impone l'immagine della memoria
come forma o strategia del desiderio. Ma il desiderio inalveato
negli strati del tempo (il tempo della storia e il tempo del
mito), è una maniera d’essere del pensiero. La
storia entro la quale il pensiero coglie i fiori del ricordo
è per la precisione la «propria» storia.
Ecco il primo vero dato di questa miracolosa sezione di vita
che è Curtelle a
1u sóue. La vita preesiste
(e coesiste) alla poesia come l'eco di una voce urlata nel
vacuo di una vallata di Tursi, e in tale condizione si rinviene
il dato conseguente all’autobiografia, il principio del
piacere «da» autobiografia. Ovvero il mestiere
di ricordar-si (di ricordare sé).
D’altra parte, pare essere un’attitudine del poeta
quella di ricrearsi (ritagliarsi) nella storia del ricordo
una frazione dolceamara di sé, quasi che la distanza
del tempo, allo stesso momento desideri «ricordare»
solo per attualizzarsi nel tempo. La filigrana «memoriale»
dei Curtelle
di Pierro consiste nella determinazione puntuale, nella fissazione
geometrica, di vaghi e sparsi luoghi della vita raccolti in
un miracoloso bacino d’eventi. Anzi, a richiamarsi da
Pierro è il «fatto» qual è l’esemplare
fisionomia dell’Evento. Non solo di vita vissuta, ma
di vita orientata ad essere tale per la presenza di un’altra
«vita», quella del poeta, seduto al centro o solo
su di un margine per osservarla tornare a sé in forma
di detriti raccolti ai suoi piedi. Pierro gravita senza controllo
psicologico sul territorio umano e linguistico della stagione
tursltana.
I1 segreto di questa poesia consiste
non già nell’allargarsi (nella lingua e nella
vita), ma nel raccogliersi, nell’adunare la parte di
sé accostandola alla parte più intima del proprio
mondo. Dall’estremità del confine (il poeta siede
idealmente altrove), l’oscillazione tra periferia e centro,
tra presente e passato, è per Pierro un luogo d’osservazione
(nel pensiero) e la maniera per inserirsi, nel «ricreando»
naturale del pensiero, entro il solco dell’autobiografia,
dell’io raccontante sé. I1 problema non è
l’«esserci» del poeta nel mondo ma –
altrimenti – solo l’«esserci stato».
L’immagine della voce poetante giunge da un pulpito al
limite del postesistenziale: un tempo esaurito nella storia
torna a vibrare nel presente, tuttavia ora è reliquia
di un trapassato sogno.
Al presente, la memoria «rivede» il tempo per
integrare il tempo. Da qui procede il doppio movimento di
questa poesia verso le età della vita, i luoghi e gli
eventi, le stagioni dell’esperienza. Da una parte, la
memoria cattura un tassello di tempo e lo fissa in un’immagine
da dagherrotipo. È l’immagine che (ri-) forgia
la «storia» del poeta.
Dall’altra tarda a fissarne l’identità alimentando
il piacere della durata visiva o mentale, quasi che il gusto
di Pierro voglia del tutto coincidere con la natura imprendibile
delle cose del mondo. È l'immagine che forgia la «cultura»
del poeta tursitano. Su questa via, la poesia di Pierro viene
a sbilanciare e mettere a soqquadro il tempo (dell’educazione
sentimentale) e il tempo generale dell’amore umano. Se
la storia obbliga a definire il tempo secondo il corso naturale
degli eventi (l’educazione «sentimentale»
alla storia), la cultura del poeta dichiara la maniera pre-naturale
dell’educazione alla
|
storia. È l’amore umano che preesiste all’educazione
sentimentale, che configura una specie d'inimicizia, che è
intrusione nei nodi nevralgici della vita del poeta. Dell’amore
umano come «condizione umana» di Pierro, e del contenuto
reale, un segno tangibile è Addie/Addio:
«Tu mó ca l’ha avute ’a pacienza di mi
legge, / purtatille appresse cchi ssempe / sta voce, / come
si pòrtete u mbrelle quanne chiòvete, / o come
ll’occhie ca vìrene u sóue, / si u core ti
dòute. // Nda tutte sti paróne, e nun su' picche,/nun
c'è manche n'arie di viléne; / na vita sèna
sèna agghie luttète / cchi'i dìcete nganne
a la morte, a schitte mò si gràpene i porte /
e addù c'èrete u scure mo c’éte u
sirene». «Tu ora che hai avuto la pazienza di leggermi,
/ portala sempre con te / questa voce, / come si porta l'ombrello
quando piove,/o come l'occhio che vede il sole, / se il cuore
ti duole. // In tutte queste parole, e non son poche, / non
c'è nemmeno l'ombra del veleno; / e solo adesso s'aprono
le porte, / e dov’era il buio c'è ora il sereno».
È nell’idea della poesia come dono, come cosa da
donare, che la pulsione originaria della poetica di Pierro stigmatizza
l'idea di parola poetica come sola eredità per il mondo.
L'immagine più naturale consiste nel principio morale
dell'offerta del proprio amore. Né la fede né
la speranza sembra siano i termini religiosi (etici o poetico-religiosi)
della donazione, ma la rarissima esigenza della carità.
Ecco allora che l'atto di pescare nel tempo non è per
lasciare «qualcosa» nel tempo ma è per donare
una «cosa» allo svolgersi del tempo.
Ciò spiega che l'amore umano è raro quanto la
carità per amore umano: così com'è fuggevole.
E pertanto Curtelle di Pierro
è da annoverarsi tra le esperienze poetiche del limite.
Del limite d'esistenza della «poesia>> nella poesia,
della «vita» nella vita. Così come accade
al poeta confuso in un sogno di benefica calamità quando
talvolta appare nel ricordo il sé fanciullo. Lungo i
gradi della propria storia come lungo i gradi, le stanze del
proprio essere, la dialettica tra l'ora e l’allora è
la messa in felicità della vita. Così leggiamo
I cose citte: «Sti
cose citte, / stu chiante ca s'ammoccete, / mó ca i'è
notte,/mi dìcene ca tòrnete / u uagnunelle ca
i'ére: / nun c'éte 'a rise com'a tanne / ma ié
le sacce scunfunnète / e vive com'a mmi/nda nn'atu grire
cchiù granne.// Po’lle sente ca tutte dui / ci iòchene
com'a frète/nda chilla vocicella amère e duce/di
nu flauticchie di canne».
Le cose silenziose: «Queste cose silenziose, /
questo pianto che si nasconde, / adesso che è notte,
/ mi dicono che ritorna / il bambino che ero: // non c'è
riso come allora / ma io lo so remoto/e vivo come me / in un
altro grido più grande. / Poi li sento tutti e due /
che giocano come fratelli/in quella vocettina amara e dolce
/ di un flauto di canna».
Non è difficile annettere alle ragioni della felicità,
non proprio il limite di una tendenza, quanto il modo d’anelare
naturale di Pierro, sempre in coesistenza amorosa con i frammenti,
ora sparsi ora raccolti, della sua vita in poesia. |
|
| |
|
| – |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|